Per chi avesse voglia di redenzione.
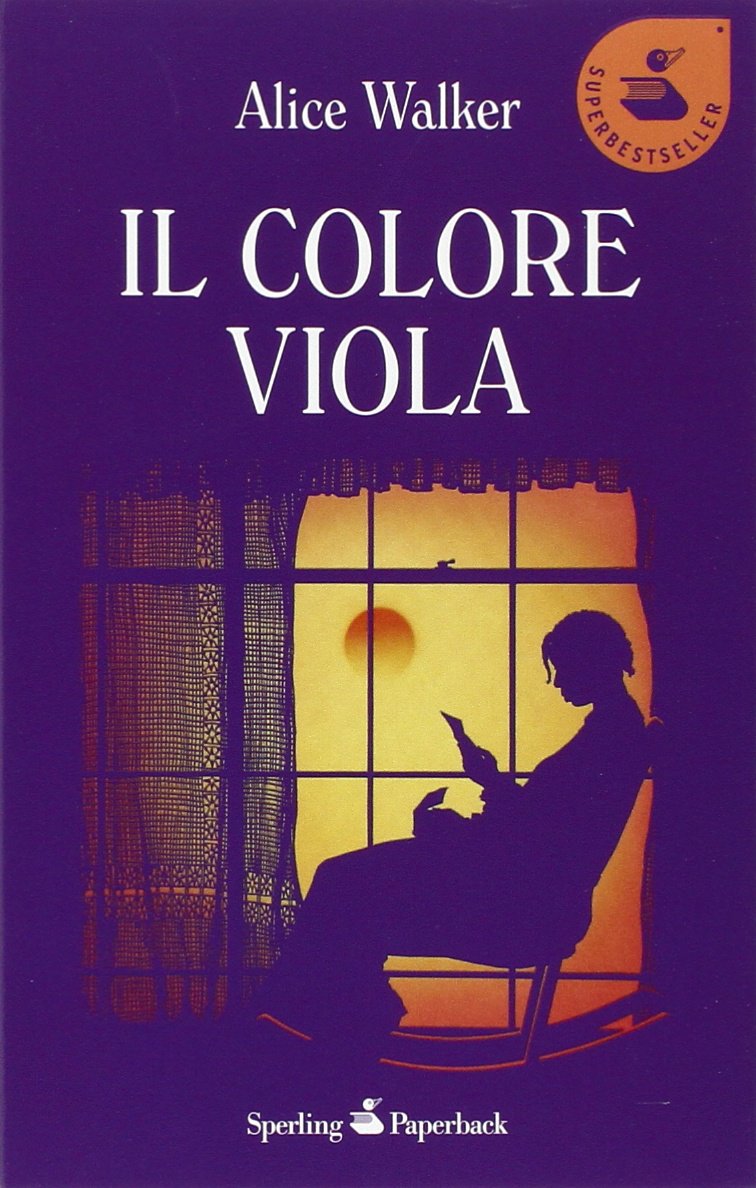
La protagonista de “Il colore viola” è Celie, una giovane donna nera che cresce nel profondo Sud americano e fin da bambina non conosce altro che violenza. Violenza fisica e psicologica, di qualsiasi genere. Il romanzo, epistolare, è una raccolta delle lettere che Celie scrive a Dio (una specie di “Caro diario”, ma più toccante) e delle missive che lei e la sorella si scrivono, senza in realtà riuscire ad avere una risposta dalla controparte. Le lettere di Celie – e quindi l’intero romanzo, unidirezionale – sono scritte in modo elementare, rozzo, in quanto si tratta di una donna semi-analfabeta, che non ha mai studiato e che ignora completamente il mondo circostante: non ne sa nulla, e quindi ne ha paura. Il romanzo è Celie: nasce con uno stupro, quasi un incesto, e procede faticosamente così come a tentoni la protagonista va avanti nel mondo, fino a trovare una propria strada. Il lettore non può che affidarsi a lei e scoprire le cose a poco a poco, sprazzi di storia e di legami umani e amore che per caso si collegano come anelli mancanti.
“L’uomo è abituato a essere al centro di tutto, non vuol cedere. Minaccia fulmini e saette, alluvioni e terremoti. Dobbiamo resistere. Io non prego quasi più. Tutte le volte che penso a un sacco, lo scaglio. Amen.”
Leggere “Il colore viola” non è facile, è un costante pugno nello stomaco. Al punto che dopo tanto dolore, l’esposione di bontà finale quasi stride con il resto. Non che Celie non la meriti: è solo poco probabile. Sarà che ho una visione pessimistica del mondo. Non credo nella redenzione collettiva. Non credo che lei dovrebbe tornare da Mister tal dei tali ed intrecciare un rapporto amichevole. Non credo che dovrebbe accogliere una donna che l’ha abbandonata per andare con un ragazzino.
Quindi non sono d’accordo con il finale, ma mi fa piacere per Celie.
E forse perché lei sa perdonare e io no.

